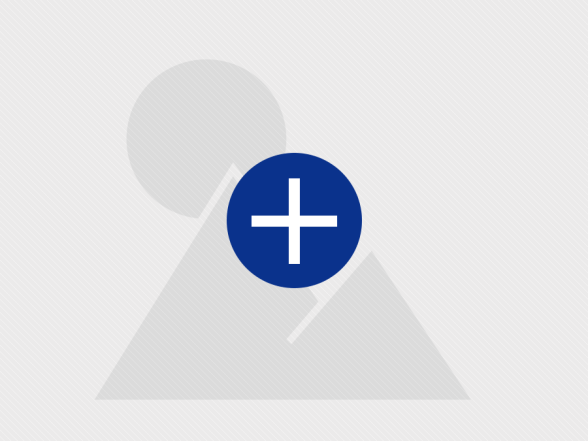SKYWATCHER 150 & 200 F5 NEWTON
Anno 2020-2021
INTRODUZIONE
Sono oramai molti anni che sul mercato amatoriale risultano disponibili strumenti newton di media dimensione a prezzi competitivi e dotati, generalmente, di ottiche di buon livello.
Tra questi sicuramente vanno ricordati i prodotti di colossi come GSO e SKYWATCHER.
E’ stato per puro caso che io sia venuto in possesso dei modelli “middle size” di SW nelle versioni 150/750 e 200/1000, entrambi con rapporto di apertura di f5 ed entrambi uguali per versione (la serie “DP” è l’ultima nata in casa SW).
Lo scopo prioritario dell’acquisto è stato quello di impiego fotografico e dunque la recensione proposta parlerà principalmente del loro impiego come astrografi, evidenziandone “pro” e “contro” e valutando quanto possano essere competivi in un mercato decisamente saturo e ben poco aiutato dalle condizioni medie dei nostri cieli.
CONSIDERAZIONI DI BASE
Tralasciando gli aspetti puramente estetici che hanno importanza relativa va premesso che i due strumenti appaiono, all’atto dell’acquisto, molto economici. Non sono i soli, i prezzi dei GSO risultano allineati, ma il dato dichiara n modo sconcertante quanto oggi sia economico realizzare un telescopio e quanto, se il nostro test ci darà impressioni positive, possa essere opinabile spendere molto per blasoni applicati a strumenti semplici come i newton.
Entrambi i tubi ottici posseggono una struttura leggera con una calandratura del tubo, un doppio anello di irrigidimento anteriore e posteriore, una cella porta primario semplice (in fin dei conti su specchi di limitato diametro come quelli in essere non servono architetture sofisticate) e uno spider del secondario con cella “aperta” e specchio semplicemente incollato ad un supporto di diametro inferiore a quello del vetro.
Su questo aspetto alcuni hanno, nel corso degli anni, espresso pareri inorriditi e scandalizzati e in linea del tutto teorica le loro critiche possono essere condivise. Dal punto di vista però squisitamente pratico, almeno su alcuni strumenti caratterizzati da diametri contenuti e rapporti focali non eccessivamente spinti, va detto che le critiche si infrangono perché gli strumenti funzionano e lo fanno anche abbastanza bene.
Sia il 6” che il 8” sono dotati di focheggiatore da due pollici con riduzione micrometrica e in entrambi i casi il posizionamento e l’ortogonalità del focheggiatore sono apparsi corretti. A questo proposito ricordo e rimando il lettore all’articolo sul TS 154/600 newton e alle disastrose condizioni di assemblaggio in cui era giunto.
In effetti, e questo anche per confessione “a denti stretti” degli importatori/distributori, i prodotti Skywatcher appaiono generalmente meglio assemblati rispetto ai GSO derivati tanto da offrire minori problemi iniziali agli utenti.
Valutati complessivamente i due newton Skywatcher appaiono ben rifiniti e peccano esclusivamente per spessore dei lamierati di costruzione che potrebbero essere realizzati in modo più robusto, prevedere barre longitudinali aggiuntive di irrigidimento e una piastra a pesi magnetici di bilanciamento laterale in caso di utilizzo visuale.
Esiste, insomma, la possibilità e lo “spazio commerciale” per una linea di prodotto parallela, più costosa e più pesante, pensata per chi impiega lo strumento in postazione fissa. In tale caso la versione da 15cm. potrebbe anche essere dimenticata e ci si potrebbe concentrare esclusivamente sulle versioni da 200 e 250mm che ritengo personalmente le più interessanti.
PRESTAZIONI VISUALI: STELLE DOPPIE E FOCALIZZAZIONE
Considerazioni evolutive a parte, i nostri due “glitterati” sono proposti al pubblico rispettivamente ad euro 320,00 circa il 15 cm. ed euro 406,00 il 20 cm. Se pensiamo che in tali prezzi, dedotta l’IVA e i dazi vari, il sacrosanto guadagno del distributore, il costo dell’oculare da 28mm in dotazione (che tutti o quasi cercano di vendere pochi minuti dopo l’acquisto), un cercatore 6x30 o 8x50, gli anelli, il “collimation tool” per agevolare la regolazione dello specchio secondario, viene effettivamente da domandarsi: ma quanto poco costa realizzare tutto questo???
E, per logica conseguenza: ma perché pagare la medesima cifra ai soliti furbetti dei mercatini a fronte di un oculare o di un tubo vintage “miracoloso” da 6 cm?
Lascio che i puri di cuori trovino in sé la risposta che preferiscono e mi concentro su altro aspetto fondamentale di uno strumento astronomico: l’ottica.
Con lieve nota polemica suggerisco di dimenticare il canto delle sirene che solitamente risuona di parole “lavorato a mano dai maestri del sushi mentre bevono sakè” e di realizzare, una volta per tutte, che oggi produrre ottiche di altissimo livello è, per una industria, un gioco da ragazzi e dipende esclusivamente dall’investimento iniziale e dal controllo sul processo produttivo.
La qualità di un’ottica dipende non dal produttore, non da quanto sia bravo il “mastro ottico” nel pulire con il suo gomito lo specchio (questo non esiste più grazie al cielo) ma dalla richiesta del committente e dal listino economico in essere. Ogni “grade” corrisponde ad un prezzo e ogni mercato sceglie, in base alla convenienza tra vendite e ricavi, il “grade” di precisione ottica richiesto.
Detto questo, in parte sconsolante, aggiungerei che il “grade minimo” corrisponde comunque a quanto riesce a fare un ottimo “mastro ottico” con le sue manine il giorno dopo aver festeggiato con la moglie una amorosa notte. Ovvero sia “quando è in buona”.
La lavorazione di uno specchio GSO o SW di oggi, tratto da un newton economico che costa come un oculare o poco più del rubicondo ciccione americano, esibisce una lavorazione ottica “eccellente”.
Se lo strumento funziona male o non al meglio il problema risiede quindi nella meccanica o nel suo assemblaggio.
I due strumenti non sono piccoli: il 150 pesa oltre 6 kg in assetto devifinito e il 200mm passa abbondantemente gli 8kg (dati solo OTA con anelli, barra vixen e cercatore di serie).
La mia esperienza con entrambi i newton SW è stata molto positiva. Anche alla “prima luce”, rigorosamente visuale per motivi tecnici e di comprensione del funzionamento dell’insieme ottica-meccanica, ha fornito risultati molto lusinghieri.
Collimare entrambi gli strumenti è stato semplice e veloce, le viti da azionare non hanno denunciato impuntamenti, filettature deboli, e si sono lasciate utilizzare in modo fluido e privo di incertezze.
Le masse vetrose non hanno denunciato errori zonali, aberrazioni sferiche rilevabili né astigmatismo di forma.
Infine, il rapporto focale di F5 consente, diversamente da quello F4, un impiego “all around” decisamente più versatile, un pizzico di focale aggiuntiva, ed una resistenza alla perdita di collimazione migliore.
Lo star test presenta in entrambi i telescopi immagini di intra ed extra focale molto simili e un punto di fuoco molto preciso e netto.
Con queste premesse ho potuto sdoppiare componenti stellari di sistemi multipli a ridosso del potere risolutore nel caso del 6 pollici e di poco superiore nel caso del 8 pollici per via esclusivamente della turbolenza atmosferica.
In entrambi gli strumenti appare facile il sistema della 33 ORI (STF 729AB) con componenti A-B separate da un angolo apparente di 1,8” e con componenti di 5.71 e 6.74.
Sia il 15 che il 20 cm. hanno mostrato anche la duplicità di STF 749AB che rappresenta un esemplare test di separazione avendo componenti di magnitudine identica (6.54 e 6.55) con separazione di 1.15”. Consiglio questo sistema nella costellazione del Toro a chiunque voglia testare separazioni prossime al secondo d’arco.
Entrambe le ottiche hanno invece “fallito” il test della BU 880AB. Il dato non mi ha stupito essendo il sistema, de facto, fuori portata ma ero curioso di capire se, almeno il 200mm, potesse quantomeno “allungare” il sistema composto da due astri di magnitudine prossima a 9.5 circa (primaria 9.28 e secondaria 9.51) con separazione angolare attuale di 0,6”.
Una bella stella “deboluccia” e singola nel 15 cm. e una altrettanto unica stella un poco meno debole ma comunque non brillante anche nel 200mm. mi hanno convinto di essermi spinto un po’ troppo oltre nelle pretese.
LUNA E PIANETI
In questo campo applicativo non credo di avere molto da dire. Dalla mia postazione di utilizzo l’eclittica è coperta per gran parte dalle fonde degli alberi e quindi non ho potuto dedicare alcuno sguardo ai pianeti maggiori se non concedere qualche veloce osservazione al terminator e lunare. Non ho svolto comparazioni con altri strumenti ma ho avuto la rinnovata sensazione che qualsiasi ottica, se ben lavorata, sappia mostrare i crateri lunari in modo entusiasmante.
In mio aiuto ho però chiamato il contributo di una amico che mi ha inviato alcune immagini scattate usando il 200/1000 a soggetti planetari. Complice un seeing di ottimo livello (candida ammissione dell’autore) il risultato ottenuto su Marte è “impressionante” e ci riporta senza molti giri di parole agli interrogativi posti in apertura.
APPLICAZIONI FOTOGRAFICHE E CARATTERISTICHE PROPRIE
Entrando in un ambito più caro agli utilizzatori di newton con rapporti di apertura classici (f5 è uno standard da moltissimi anni) ho effettuato alcuni test usando tradizionali oculari plossl moderni.
Il responso è un’ottica (in entrambi i casi) che lavora molto bene fino a circa 2/3 del campo inquadrato. Oltre tale distanza dal centro cominciano a risultare sibili distorsioni geometriche introdotte dalla curvatura di campo.
Usando oculari con FOV apparente di circa 50° l’effetto risulta non molto fastidioso e permette di godere di immagini globalmente valide anche ad ingrandimenti medio/bassi.
Se però tentiamo di introdurre nel sistema ottico oculari grandangolari (ho provato sia dei vecchi Meade SWA serie 4000 da 68° che dei moderni SWA da 70°) l’effetto si amplifica e la distorsione a bordo campo diventa più marcata e fastidiosa.
Il medesimo problema si verifica, ovviamente, in campo fotografico.
I test sono stati condotti con 3 camere CMOS moderne diverse: una ASI 178mono, una ASI 533pro colore, una ASI 294pro colore.
Da specifiche tecniche le tre camere posseggono diagonali (espresse in millimetri) rispettivamente di 8,92mm., 16mm., 21,63mm., con la peculiarità che la la ASI 533 propone un formato quadrato.
Sul formato della ASI 178, il campo disegnato dai due newton appare “corretto” e si può pensare di fotografare senza patemi anche al fuoco diretto privo di correttori.
Se però ci si sposta su sensori con superficie maggiore, in questo caso sia con la ASI533 e ancor di più con la 294 (che è tra l’altro un 4/3) risulta obbligatorio l’acquisto di un correttore di coma se si desidera un fotogramma con stelle puntiformi anche ai bordi.
Se questo funziona benissimo “in teoria”, in pratica bisogna fare i conti anche con altri problemi che personalmente ritengo più “ostici” da risolvere.
Gli strumenti come i due SW oggetto del nostro articolo (ma potremmo prenderne in considerazioni altri concorrenti, o anche più costosi e blasonati) nascono tendenzialmente con una logica di “tutto fare” e quindi presuppongono che l’utilizzatore li impiaghi sia per fotografare che per guardare il cielo. Questo fa sì che la raccorderia abbia una logica prettamente “visualista” con innesti a pressione (lardoni) e non a “vite” come imporrebbe il treno ottico “da manuale” del “giovane astrofotografo”.
Le tolleranze costruttive (ancor peggio se abbiamo la sventurata idea di impiegare i blasonati raccordi autocentranti prodotti da emeriti imbecilli) fanno sì che gli assi ottici tendano a subire le flessioni della meccanica con la conseguente introduzione di aberrazioni geometriche asimmetriche.
Correggere tali problemi è possibile, magari montanti in verticale i raccordi e le camere di ripresa, ma richiede poi di lasciare lo strumento così come lo abbiamo preparato e sistemato. Se lo spostiamo, smontiamo, cambiamo camera, tutto richiede di ripartire da capo con prove e aggiustamenti vari sino a raggiungere l’equilibro adatto tra i vari componenti.
Se invece il sistema fosse gestito solamente da raccordi a vite i patemi del fotografo sarebbero largamente superati. In tale caso, ovviamente, ci sarebbero maggiori difficoltà per un impiego visuale.
Quando tutto è “a posto” o quasi, i due newton lavorano bene e sono capaci di scattare fotografie con un buon contrasto e una ottima puntiformità stellare.
Le loro focali di 750mm e 1000mm, unite al peso del 8 pollici che in configurazione di ripresa con telescopio guida, camera, cavi etc, supera abbondantemente gli 11/12kg, impongono l’impiego di montature di portata della classe della EQ6 o superiori e una certa capacità di gestire i sistemi di guida, l’allineamento polare, le esposizioni e in generale la preparazione del set-up con particolare attenzione al bilanciamento sulla montatura.
Non me ne voglia nessuno ma, sebbene il prezzo di acquisto sia molto interessante, sconsiglierei qualsiasi principiante dall’acquistare un simile telescopio per fotografare il cielo mentre vedo il 200/1000 sicuramente adatto al fotografo esperto che sia in grado di farlo lavorare al massimo delle sue capacità e quindi possa estrarne, da cieli di buon livello, immagini spettacolari.
Purtroppo, oltre non essere un fotografo capace (o meglio, sono sicuramente bravo a riprendere ma poi, per scelta, NON elaboro le immagini) sono stato anche costretto a riprendere da un cielo di classe Bortle 9+ da cui ho potuto trarre solo poche immagini definibili “decenti” che allego in calce.
Altra considerazione va fatta sulla lunghezza focale dei due strumenti e sul loro migliore impiego o “scelta”.
Sebbene non fruibili nell'imaging a cosiddetto “grande campo”, utilizzare focali da 750mm o 1000mm. non è esattamente la medesima cosa.
Tralasciando la maggiore attenzione alla guida e ai sistemi di inseguimento, oltre al peso superiore, imposti dal 20 cm., il campo inquadrato da 0,75 o 1 metro su sensori tipici della produzione attuale a “budget 1000 euro” può decretare la scelta di uno o dell’altro strumento. Con nessuno dei due sarà infatti possibile, a meno di non impiegare una DSLR full frame, fotografare per esteso le nebulose diffuse famose ma bisognerà indirizzare la propria attenzione su soggetti più specifici: ammassi globulari, galassie o cluster di queste, ammassi aperti non troppo estesi (comunque quasi tutti quelli disponibili nei vari cataloghi) e planetarie “non” troppo piccole (poiché a 750mm. o 1000mm. risulterebbero eccessivamente minute sul fotogramma).
La scelta quindi di uno strumento a focale media come quelli indicati è e resta una scelta che impone dei limiti.
Solitamente chi opta per uno strumento simile da utilizzare in astrofotografia lo fa per affiancare un più veloce e ampio rifrattore da 6/7 cm aperto a f6 che consente di avere ampia porzione di cielo alla portata del sensore di acquisizione.
Se si dispone quindi di un cmos o ccd di superficie sufficientemente ampia consiglio di rivolgersi al 200/1000, se invece si vuole eseguire imaging del cielo profondo impiegando o convertendo all’uso deep sky i sensori planetari oggi in voga (con diagonali molto piccole) conviene decisamente scegliere il 150/750.
Date le loro caratteristiche di velocità di ripresa (e ricordiamoci che un F5 non è affatto disprezzabile come scelta fotografica) i due strumenti si prestano molto bene all’impiego di tecniche come il live stacking multiposa a tempi di singola ripresa relativamente brevi (dai 5 ai 30 secondi). In questo caso non abbiate paura ad alzare il “gain” di ripresa e sfruttare quindi i cmos più moderni che esibiscono un rumore di lettura molto basso e gestiscono bene alte velocità di acquisizione e frame transfer.
CONCLUSIONI
I due newton Skywatcher costano poco e propongono lunghezze focali interessanti e centrate per l’astrofotografo interessato alla ripresa di oggetti non eccessivamente estesi (quindi ammassi globulari, galassie, molti ammassi aperti, molte nebulose) mantenendo veloci i tempi di ripresa.
Vanno impiegati su montature solide e ben bilanciate, richiedono un minimo di collimazione preventiva ma tendono poi a tenerla bene.
Come moltissimi strumenti in circolazione hanno il loro punto debole nella raccorderia fotografica che va accuratamente montata e bilanciata pena l’introduzione di aberrazioni asimmetriche.
In visuale non fanno rimpiangere altre configurazioni ottiche né in alta risoluzione né a basso ingrandimento. A parità o comparabilità di prestazione va però considerata la scomodità intrinseca dello schema newton nell’impiego visuale quanto installato su montature equatoriali oltre alla impossibilità di bilanciamento corretto. Questi due aspetti sono a mio modo di vedere fondamentali tanto da farmi sconsigliare i newton derivati par impiago visuale a meno che non siano in configurazione dobsoniana.
Ritengo invece che sia il 150/750 che il 200/1000 siano a tutti gli effetti astrografi dalle ottime prestazioni. Possono essere migliorati con sistemi di raccordi realizzati ad “hoc” pur mantenendo un costo finale che è una frazione di quello richiesto da nomi più blasonati o dalla voluttuaria presenza di carbonio o di nastrini colorati vari nei tubi ottici…